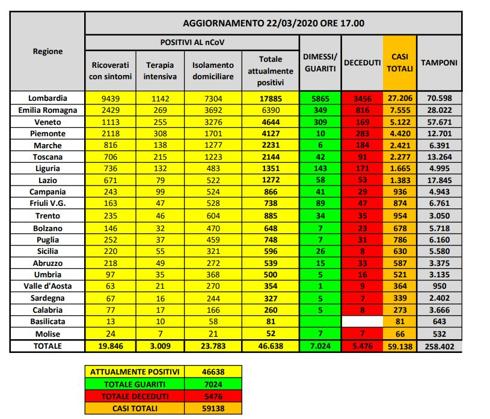di Gerardo Pecci
La fotografia come documento o come testimonianza? Siamo abituati a considerare la fotografia quale attività che serve a “dimostrare” l’oggettività, la testimonianza di ciò che è stato o di ciò che è. In realtà non è esattamente così perché ogni immagine fotografica è sempre una scelta, un momento personale immortalato dall’occhio del fotografo che sceglie il soggetto da riprendere, il momento propizio e l’inquadratura adatta. È l’atto della scelta ciò che fa la differenza tra un’immagine qualsiasi e una fotografia, secondo l’occhio e la sensibilità umana e professionale del fotografo. Esistono tanti “generi fotografici” e sono anch’essi frutto di una scelta sociale, “ideologica” e iconica, del fotografo: c’è, ad esempio, chi s’interessa della fotografia pubblicitaria e di moda, chi sceglie invece come campo d’azione l’antropologia, chi s’interessa della fotografia sociale e giornalistica, chi del fotogiornalismo di guerra.
Il fotogiornalismo di guerra, il reportage fotografico bellico, è anch’esso un filone molto importante della storia della fotografia. Tutti ricordiamo le foto di Robert Capa, ad esempio. Ma è solo uno dei tanti fotografi di guerra, tra tanti altri che nel tempo hanno rischiato la vita o sono morti per documentare momenti estremi di combattimenti e di battaglie. Questo genere fotografico è nato sui campi di battaglia del XIX secolo, nella guerra di Crimea, nel 1855, dove il fotografo Roger Fenton documentò i morti in battaglia e poi pensiamo anche ad Alexander Gardner che invece documentò la guerra di secessione americana. E via via tutti gli altri fotografi che hanno seguito le orme di questi primi due pionieri della macchina fotografica in guerra.
Questo filone fotografico nasce dunque da una scelta personale, o di lavoro, di documentare in diretta gli orrori delle battaglie mostrando momenti di vita vissuta all’insegna della tragedia e della follia dei massacri e i volti di chi è costretto a combattere, di chi è in attesa dell’assalto, dello scontro con un nemico altrettanto impaurito e con la concreta possibilità di poter morire o essere feriti in battaglia. Il fotografo di guerra ha piena consapevolezza che la morte è in agguato e che il proprio lavoro deve contemplare la concreta possibilità di morire.
Chi rischia, con la macchina fotografica a tracolla, lo fa con la certezza della possibilità di rendere un servizio pubblico, per documentare giornalisticamente ciò che accade e, in certa misura, lavora anche per la storia, per far conoscere al mondo le tragedie delle guerre. Per fare il fotoreporter di guerra ci vuole un amore vero e concreto per la fotografia, ma è indispensabile avere coraggio e una motivazione fortissima per affrontare indicibili disagi, quasi gli stessi dei soldati in prima linea e una capacità non comune per documentare in maniera professionale anche scene davvero strazianti e raccapriccianti. Si tratta di una lotta anche con se stessi, per esorcizzare la costante e onnipresente paura di morire da un momento all’altro. Non si tratta di essere “eroi” per forza o per vocazione, ma di essere persone che vogliono mostrare agli altri le tragedie delle guerre con i loro orrori, con il carico di morti che ogni conflitto armato porta inevitabilmente con sé, sia per quanto riguarda le truppe coinvolte nei conflitti che per quanto riguarda la documentazione della distruzione delle città e la morte di civili inermi, soprattutto donne e bambini innocenti.
L’occhio del fotografo diventa, così, la coscienza del dolore e della morte, ma può essere anche la luce nel buio, la denuncia e l’urlo contro l’irrazionalità e il misero fallimento della politica. La macchina fotografica diventa l’occhio della coscienza di un’umanità malata, ferita, che ha perduto il senso del rispetto, dove l’uomo diventa parte dell’ingranaggio di una macchina di morte agli ordini di altri esseri umani che ubbidiscono solo alla logica della distruzione e della conquista, in nome di ideologie che offendono e annientano gli stessi valori della vita.
Il fotografo di guerra sceglie, ricerca, valuta, guarda ciò che si sente di fotografare, coglie aspetti variegati e complessi di un’umanità dolente dove coloro che combattono e anche quelli che sono vittime e testimoni fanno parte di un ingranaggio che finisce per stritolare la coscienza e imbavagliare la stessa volontà di pace. In questo complesso lavoro il fotografo non può essere mai neutrale nel senso che il suo occhio è in grado di scegliere momenti, aspetti e sentimenti capaci di suscitare in noi emozioni che ci coinvolgono e ci rendono, in certo modo, testimoni indiretti. Noi vediamo e valutiamo attraverso l’occhio del fotografo, attraverso l’immagine e il suo taglio fotografico, attraverso la messa in codice dell’immagine voluta e realizzata dalla mente del fotografo. Ed è proprio la “messa in codice” dell’immagine fotografica che la significa, che le dà un senso, essa sovente è capace di coinvolgerci emotivamente e catapultarci nei campi di battaglia, insieme a chi soffre e a chi muore. Noi che vediamo le fotografie siamo al sicuro. Siamo soltanto dei “testimoni” indiretti, assistiamo iconicamente al dolore e agli orrori di tutte le guerre che uccidono le nostre coscienze e la nostra stessa umanità.